Un’antica meraviglia che riemerge | La Necropoli di Ramacca e un'antica rivelazione
Nella Montagna di Ramacca, vicino Catania, una necropoli eneolitica mostra corredi di rame e ceramiche che raccontano 5 mila anni di vita nel Calatino.

L’enigma delle cento tombe scolpite nella roccia
A poco più di quaranta chilometri da Catania, sulla dorsale chiamata Montagna di Ramacca, gli archeologi dell’Università di Catania e della Soprintendenza hanno censito oltre 120 sepolture dell’Età del Rame (III millennio a.C.): camere ipogee ovali, loculi “a forno” e grotticelle artificiali scavate in calcarenite, disposte in nuclei lungo i fianchi del colle. Le undici campagne di scavo (1978-2000, dirette da Enrico Procelli e Andrea Patanè) hanno restituito pugnali lamellari, punteruoli, spirali-bracciale in rame arsenicale, perle di conchiglia e ciottoli di pietra levigata che documentano l’adozione della metallurgia nella Piana di Catania e scambi a lunga distanza con le coste ioniche. Straordinario il ritrovamento di vasi globulari decorati a pettine: la stessa matrice stilistica ricorre nei grandi centri calatini di Occhiolà e Paliké, prova di una rete culturale già salda tremila anni prima dei Greci. Oggi il comprensorio – tre necropoli, due aree sacre protostoriche e il villaggio di Torricella – è visitabile su prenotazione come Parco Archeologico di Ramacca, con sentieri che dominano la vallata dorata dei cereali che hanno fatto la fortuna dei catanesi panificatori.
Corredi, riti e misteri: cosa raccontano gli oggetti del Rame
Gli studiosi di “Cronache di Archeologia” hanno analizzato oltre 1 500 reperti: lame “a foglia di alloro” forgiate con minerali etnei, lame in selce importata dall’area siracusana, anelloni in osso, pendagli a occhiali e vasellame con motivi a zig-zag inciso. Le deposizioni multiple, spesso distinte da bracciali spiraliformi che segnano rango o genere, indicano una società già stratificata; in alcune tombe è comparso il cinabro usato per dipingere di rosso i corpi, gesto simbolico collegato alla rigenerazione solare. Accanto alle sepolture, un’area di culto a cielo aperto mostra pietre altari annerite dal fuoco e frammenti di coppe votive: segni di banchetti funebri e di offerte collettive che uniscono vivi e morti in un medesimo orizzonte cerimoniale.
Curiosità
Secondo datazioni radiocarboniche eseguite a Catania, l’uso della necropoli oscilla tra 3350 ± 40 BP e 2600 ± 45 BP, ponendo Ramacca tra i più antichi complessi eneolitici della Sicilia orientale. Il sito, sorvegliato dalla Soprintendenza, è un laboratorio a cielo aperto dove scuole e università “adottano” tombe per campagne didattiche, trasformando la Montagna in un’aula di preistoria viva.
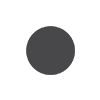 10.7°
10.7°


